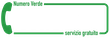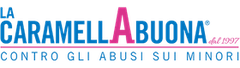In dubio pro reo non può significare: nel dubbio, distruggiamo la vittima
Il principio del in dubio pro reo è il cardine di ogni ordinamento giuridico democratico. La presunzione di innocenza, il diritto alla difesa, la possibilità per l’imputato di contestare ogni accusa sono garanzie irrinunciabili. È proprio su questi pilastri che si fonda la giustizia. Ma quando questi diritti diventano strumenti per demolire la dignità della persona offesa, allora qualcosa si spezza. E ciò che resta, troppo spesso, non è più un processo, ma una forma subdola di abuso istituzionalizzato.
Nel processo per stupro di gruppo che vede imputati quattro ragazzi, la giovane donna che ha denunciato è stata sottoposta a 1675 domande durante la sua testimonianza. Un processo nel processo.
Sette ore di interrogatorio, in cui non si è cercato solo di capire cosa sia successo quella notte d’estate e di orrore nel 2019, ma di scandagliare (e mettere in discussione) ogni aspetto della sua identità, della sua sessualità, della sua emotività.
Nel corso della sua deposizione, la ragazza è stata sottoposta a 1675 domande. È giusto ribadirlo perché non si tratta di un’iperbole puramente retorica: è un dato documentato. In sette ore di udienza, le è stato chiesto di tutto. Le hanno chiesto cosa indossava, se aveva bevuto, perché era rimasta nella casa, perché aveva sorriso, perché era andata al mare il giorno dopo. Le hanno chiesto se aveva provato piacere. Se aveva mai avuto rapporti simili.
Una raffica di quesiti che, per mole e natura, ha finito per ribaltare la posizione delle parti: la denunciante è diventata l’interrogata, l’imputato è diventato osservatore, e il processo si è trasformato in un laboratorio di rivittimizzazione.
Come se la violenza potesse essere misurata in base alla coerenza di un comportamento.
Come se il dolore dovesse rispettare uno schema.
Questa non è la ricerca della verità. È vittimizzazione secondaria: una forma di violenza esercitata non dal carnefice, ma dalle istituzioni stesse.
Succede quando la vittima viene esposta a uno stillicidio di domande insinuanti, a giudizi impliciti, a un processo di smantellamento psicologico che ha un solo obiettivo: mettere in dubbio la sua credibilità.
E tutto questo nel nome del “diritto alla difesa”. Sia chiaro: nessuno qui intende mettere in discussione il diritto di chi difende l’imputato di interrogare la testimone. Anzi, è proprio il rispetto delle garanzie processuali a distinguere una giustizia degna di questo nome dal giustizialismo sommario. Ma ogni diritto, anche quello alla difesa, ha un limite: quello del rispetto, della proporzionalità, della non violenza. Quando si sottopone una giovane donna a un fuoco incrociato di oltre mille domande, molte delle quali ridondanti, morbose, umilianti, non siamo più nel terreno del garantismo. Siamo nell’abuso.
Non si deve trasformare il processo in un palcoscenico per lo screditamento morale di chi denuncia.
Non si deve insinuare che se lei non ha urlato, allora voleva.
Che se ha bevuto, allora ha acconsentito.
Che se ha continuato a vivere, allora non ha sofferto abbastanza.
Questo modo di interrogare non è neutro. È figlio di una cultura dello stupro che resiste sotto la superficie del diritto. Quello che accade in aula è lo specchio di ciò che accade nella società.
Le donne che denunciano sanno che il percorso sarà doloroso, lento, esposto e sanno che la loro versione verrà messa alla prova perché fortemente condizionata da una cultura così radicata che non si limita a giustificare la violenza, ma trasforma il sospetto sulla vittima in una pratica giudiziaria legittimata.
Una cultura che non chiede “cosa ti è successo?”, ma “perché non hai fatto abbastanza per evitarlo?” Questa cultura, processuale e non, non è solo inadeguata. È pericolosa. Perché alimenta la più tossica delle convinzioni: quella secondo cui chi denuncia uno stupro dev’essere prima di tutto sospettata, esaminata, decostruita. E se cade in contraddizione, se non piange al momento giusto, se si è comportata in modo “troppo normale” nei giorni successivi, allora perde automaticamente credibilità. Questo è il cuore pulsante della cultura dello stupro: quel sistema di credenze che, anche senza giustificare esplicitamente la violenza, la normalizza, la rende ambigua, la relativizza, la rende colpa della vittima.
Non si tratta di negare la complessità dei casi giudiziari. Non si tratta nemmeno di pretendere condanne senza prove. Si tratta di chiedere che il percorso della vittima nel processo non diventi un secondo calvario. Si tratta di riconoscere che la violenza sessuale lascia segni profondi, spesso incompatibili con le aspettative stereotipate del “comportamento della vera vittima”. Si tratta di costruire una cultura della giustizia in cui difendere non significhi aggredire e in cui la ricerca della verità non sia una scusa per la tortura psicologica.
Le 1675 domande non sono solo un numero. Sono il simbolo di un sistema che ha ancora paura di credere alle vittime imperfette. Un sistema che confonde garantismo con crudeltà, che scambia il diritto alla difesa con il diritto alla demolizione. Non possiamo accettarlo. Possiamo (e dobbiamo) pretendere che il processo resti giusto per tutti, ma che non trasformi la vittima in bersaglio.
Perché il dubbio deve tutelare l’imputato.
Ma la dignità deve proteggere la persona che ha trovato il coraggio di parlare.
Perché se davvero vogliamo giustizia, dobbiamo iniziare a chiederci:
quante donne tacciono, ogni anno, perché hanno paura di essere trattate come lei?
E quante continueranno a subire, finché il processo resterà un luogo in cui il trauma non si ascolta, ma si mette in discussione?
Per maggiori informazioni contatta La Caramella Buona
Se sei vittima di un abuso, oppure conosci qualcuno vittima di abusi, ricorda che, la prima cosa da fare, è contattare le Forze dell’Ordine facendo presente la situazione.
Qualora dovessi sentire la necessità di un supporto morale per intraprendere questo percorso potrai contattare La Caramella Buona al numero verde 800.311.960, scrivendo alla mail segreteria@caramellabuona.org, oppure attraverso gli altri contatti presenti sul nostro sito.
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina FAQ.
Alessia Lazzaroni