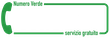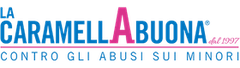Il femminicidio è diventato reato autonomo, ma senza prevenzione, educazione e protezione concreta, rischia di essere solo una parola in più nei tribunali. E troppo poco nella vita reale delle donne
Il 23 luglio 2025, il Senato ha approvato all’unanimità l’introduzione del reato autonomo di femminicidio nel codice penale italiano, tramite l’art. 577-bis c.p.. Da oggi, chi uccide una donna “in quanto donna”, per odio di genere, rifiuto affettivo o volontà di dominio, sarà punito con l’ergastolo. Un voto senza contrari né astenuti, considerato da molti come una svolta storica. Ma quando ci si ferma a guardare oltre il titolo, il disegno di legge rivela tutta la sua fragilità: un provvedimento che non salva vite, non previene nulla, e che anzi perpetua la logica emergenziale e repressiva che da anni fallisce sistematicamente nel contenere il fenomeno. In altre parole, una risposta legislativa tardiva, utile solo a coprire il vuoto delle politiche pubbliche realmente necessarie.
Perché punire con l’ergastolo chi uccide una donna in quanto donna significa intervenire dopo. È un modo per dire “abbiamo fatto qualcosa”, senza affrontare davvero il cuore del problema.
Dal punto di vista simbolico, questa norma rappresenta indubbiamente una rottura con il passato. Per anni si è parlato di “delitti passionali”, si è usato il termine “raptus”, si è cercata una spiegazione psicologica o relazionale alle uccisioni di donne da parte di compagni, mariti, fidanzati o ex. Ora la legge fa un passo in avanti: riconosce che si tratta di omicidi che hanno una radice strutturale e culturale, e che derivano da una mentalità patriarcale che considera la donna una proprietà, un oggetto da controllare o eliminare quando non risponde alle aspettative. Ma una legge può davvero bastare da sola? Serve davvero una nuova fattispecie di reato per contrastare il femminicidio? Oppure lo usiamo come uno specchio per le allodole mentre ignoriamo il bisogno di altri strumenti, come educazione e risorse?
È qui che iniziano le critiche più profonde.
In primo luogo, l’impianto della legge si concentra solo sul momento terminale della violenza: l’omicidio. Non si occupa minimamente del prima. Non parla di prevenzione, non interviene sulla rete dei servizi sociali e territoriali, non propone alcuna misura per rafforzare i centri antiviolenza, né prevede fondi per l’educazione affettivo-sessuale nelle scuole, che è oggi uno degli strumenti più efficaci per prevenire la violenza di genere. Il rischio, insomma, è che questa legge finisca per essere un gesto simbolico, che arriva sempre tardi: quando una donna è già stata uccisa.
I dati, purtroppo, confermano che il problema è tutto nella prevenzione. Secondo il report 2024 della rete nazionale D.i.Re (‘Donne in Rete contro la violenza’) ben 23.851 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza nell’ultimo anno. Si tratta di numeri in crescita, che segnalano da un lato una maggiore consapevolezza, ma dall’altro la persistente diffusione della violenza contro le donne. Eppure, nonostante questa emergenza, quasi mille donne non hanno trovato un posto in una casa rifugio. Solo il 32% ha sporto denuncia. Questo dato è cruciale: significa che più di due donne su tre non si sentono sufficientemente tutelate da un sistema che ancora oggi lascia le sopravvissute sole, senza protezione, senza ascolto. Lo Stato resta assente, proprio quando dovrebbe esserci.
Questo dimostra che le donne non sono libere di chiedere aiuto, e che lo Stato non è ancora in grado di proteggerle prima che sia troppo tardi. Senza risorse adeguate, senza formazione specifica per le forze dell’ordine, senza protocolli chiari per la presa in carico delle segnalazioni, le denunce restano spesso carta straccia. Molte donne si rivolgono ai centri antiviolenza prima ancora di denunciare, proprio perché hanno bisogno di ascolto, orientamento, sicurezza. Ma questa rete, portata avanti da 3.739 attiviste, spesso in condizioni di sotto-finanziamento, non è sufficientemente riconosciuta né sostenuta dalle istituzioni.
E poi c’è il nodo culturale. Nel testo appena approvato non c’è traccia di un piano educativo nelle scuole. Nessuna menzione all’educazione affettivo-sessuale, all’alfabetizzazione emotiva, alla decostruzione degli stereotipi di genere. Le aule scolastiche, che dovrebbero essere il primo spazio di prevenzione, sono ancora oggi escluse da ogni politica sistemica sul contrasto alla violenza. Come possiamo credere che una legge penale, per quanto necessaria, possa bastare, se continuiamo a educare i ragazzi alla virilità tossica, al controllo, alla gelosia come prova d’amore? Se lasciamo che le ragazze crescano senza strumenti per riconoscere relazioni manipolatorie, senza sapere che dire “no” è un diritto e non una colpa? Eppure, i giovani crescono immersi in una cultura pornografica e sessista, senza strumenti per interpretare o difendersi. Parlare di consenso, di emozioni e rispetto resta un tabù politico. Non per mancanza di consapevolezza, ma per calcolo politico: parlare di affettività, di corpo, di genere, significa scontrarsi con i conservatori. E allora si tace e si rinvia; ma nel frattempo le vittime aumentano.
La legge non dice nulla di tutto questo. E forse è per questo che lascia l’amaro in bocca. Perché mentre introduce un nuovo reato, non tocca le cause profonde della violenza. Non cambia ciò che la alimenta ogni giorno. Non previene, non educa, non protegge abbastanza. Si affida ancora una volta alla punizione, come se fosse sufficiente minacciare l’ergastolo per fermare la mano di chi vuole uccidere. Ma chi arriva a quel gesto estremo lo fa quasi sempre dopo una lunga escalation di abusi, di soprusi, di segnali ignorati. Che possono essere fermati in tempo con un po’ di consapevolezza e attenzione in più.
Perfino da un punto di vista giuridico, c’è chi solleva dubbi. L’omicidio aggravato da motivi abietti o futili, o dalla relazione affettiva, già consentiva ai giudici di riconoscere e punire adeguatamente un femminicidio. Creare una nuova fattispecie autonoma può sembrare ridondante, o peggio, creare confusione. Si rischia di creare una sorta di “doppio binario” del diritto penale, che può dare luogo a interpretazioni non uniformi, o che può paradossalmente depotenziare la qualificazione di altri reati di violenza contro le donne.
Eppure, il femminicidio non è solo una questione giuridica. È un fenomeno che riguarda la cultura, i media, l’educazione, le relazioni. Serve una strategia integrata, che cominci ben prima del reato, e si estenda ben oltre il tribunale. Serve formazione, supporto psicologico, empowerment economico, rifugi sicuri, una rete che accompagni le donne nella libertà, non solo nella sopravvivenza.
Il ministro Nordio, tempo fa, suggeriva alle donne in pericolo di “rifugiarsi in una chiesa o in una farmacia” in attesa della polizia. È la resa dichiarata del potere pubblico. Una dichiarazione che ha fatto discutere, ma che riassume perfettamente lo spirito di questa legge: lo Stato arriva tardi, troppo tardi, e nel frattempo si limita a osservare da lontano, invocando il caso, la fede, il coraggio delle vittime in assenza di un piano efficace. Ma il coraggio, da solo, non basta. Servono strutture e operatori formati. Servono risorse certe, non bandi a singhiozzo assegnati con anni di ritardo, come quello del 2022 (due milioni di euro distribuiti solo all’inizio del 2025.)
Il DDL prevede altresì alcuni miglioramenti procedurali: estensione delle intercettazioni oltre i 45 giorni, audizione delle vittime, formazione dei magistrati. Ma è una riforma a metà. Perché non coinvolge forze dell’ordine, insegnanti, sanitari, assistenti sociali. Perché continua a muoversi nella logica dell’emergenza e non in quella della prevenzione. Perché resta cieca davanti alla realtà: le donne non chiedono solo giustizia postuma. Chiedono di non morire.
Ogni tre giorni, in Italia, una donna viene uccisa. E il dato più inquietante non è la frequenza. È la prevedibilità. Sono gli ammonimenti ignorati, le denunce archiviate, le segnalazioni sottovalutate. Sono le storie che si ripetono identiche, fino all’epilogo tragico. E mentre il governo si compiace dell’ergastolo simbolico, resta in silenzio sul fatto che la maggior parte delle vittime aveva già chiesto aiuto.
Introdurre il reato di femminicidio non è un errore in sé: è un errore presentarlo come risposta risolutiva a un fenomeno così profondo e complesso. È un errore usarlo come alibi per non fare tutto il resto. È un errore usarlo come scudo mentre si continua a tagliare i fondi, a ignorare le richieste dei centri antiviolenza, a restare inerti davanti alle denunce ignorate. È un errore nascondersi dietro la parola “giustizia” mentre si rinuncia a garantire vita. Senza fondi ai centri antiviolenza, senza reddito di libertà realmente accessibile, senza educazione al consenso, senza un Piano Strategico Nazionale aggiornato e operativo, questa legge resterà una bandiera issata sul nulla.
Una società che non forma chi diventerà uomo, continuerà a produrre carnefici.
Una società che non insegna alle ragazze a riconoscere i segnali della violenza, continuerà a crescere vittime.
Il punto non è solo dare un nome giusto alla tragedia. È cambiare tutto quello che la rende possibile, normale, quotidiana. E questa legge, per ora, non lo fa. Dà un nome al problema, ma non lo risolve.
Per maggiori informazioni contatta La Caramella Buona
Se sei vittima di un abuso, oppure conosci qualcuno vittima di abusi, ricorda che, la prima cosa da fare, è contattare le Forze dell’Ordine facendo presente la situazione.
Qualora dovessi sentire la necessità di un supporto morale per intraprendere questo percorso potrai contattare La Caramella Buona al numero verde 800.311.960, scrivendo alla mail segreteria@caramellabuona.org, oppure attraverso gli altri contatti presenti sul nostro sito.
Per maggiori informazioni visita la nostra pagina FAQ.
di Alessia Lazzaroni