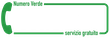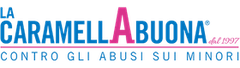In Italia la violenza sulle donne continua a essere una piaga sociale diffusa. Solo nei primi 7 mesi del 2025, il Viminale riporta 60 femminicidi e oltre 7.500 casi di stalking e violenza domestica registrate dalle questure di tutta Italia.
La legge italiana riconosce la violenza di genere come una grave violazione dei diritti umani, punita con pene severe e percorsi di protezione specifici per le vittime. Riconoscere i segnali, sapere come reagire, conoscere le leggi e i propri diritti è fondamentale per uscire dalla violenza.
In questa pagina realizzata da La Caramella Buona troverai risposte chiare alle domande più frequenti: cos’è la violenza di genere, come riconoscerla, cosa fare per denunciare, quali sono le tutele previste dalla legge e come ricevere aiuto concreto.
Attenzione: questa guida ha uno scopo informativo e non sostituisce il supporto di professionisti. Se sei in pericolo chiama subito il 1522 o le forze dell’ordine.
Indice dei contenuti
- Cos’è la violenza sulle donne e di genere?
- Quali sono i tipi di violenza contro le donne?
- Quali sono le leggi contro la violenza sulle donne?
- Come riconoscere i segnali di violenza?
- Cosa fare se sei vittima di violenza
- Come denunciare: procedura legale
- Tempi e funzionamento del processo penale
- Supporto psicologico e legale per donne vittime
- Prevenzione e sensibilizzazione
- Se sei una donna vittima di violenza, non sei sola.
Cos’è la violenza sulle donne e di genere?
La violenza sulle donne comprende ogni forma di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica rivolta contro una donna in quanto donna. È riconosciuta come una grave violazione dei diritti umani e viene punita dalla legge italiana. La violenza di genere comprende in senso più ampio tutte le forme di oppressione e discriminazione basate sull’identità di genere.
Cos’è la violenza sulle donne?
La violenza sulle donne è definita dall’ONU come “ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia come risultato, o possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata”.
In Italia, la violenza sulle donne è regolata da un quadro normativo articolato, rafforzato nel tempo per garantire protezione e diritti alle vittime. Il principale riferimento è la Convenzione di Istanbul, ratificata con la Legge 77/2013. Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che prevede:
- un quadro globale di protezione,
- politiche di prevenzione,
- misure concrete di assistenza alle vittime,
- cooperazione internazionale per eliminare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.
L’articolo 3 della Convenzione stabilisce che la “violenza nei confronti delle donne” rappresenta una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, comprendendo tutti gli atti di violenza basati sul genere che causano o possono causare danni fisici, sessuali, psicologici o economici, incluse le minacce, le coercizioni o le privazioni arbitrarie della libertà, sia nella sfera pubblica che in quella privata
Come si manifesta la violenza sulle donne?
Le forme più comuni di violenza sono:
- Violenza fisica: aggressioni, percosse, lesioni.
- Violenza psicologica: umiliazioni, insulti, minacce, isolamento.
- Violenza sessuale: costrizione a rapporti o atti sessuali non voluti.
- Violenza economica: privazione dei mezzi di sostentamento, controllo delle risorse economica.
- Violenza assistita: quando i figli assistono agli abusi sulla madre.
Queste modalità possono coesistere, rendendo la situazione ancora più complessa da affrontare.
Quando è considerata violenza sulle donne?
La violenza sulle donne è riconosciuta dalla legge italiana anche in assenza di segni fisici evidenti. Non è necessario subire percosse per essere considerata vittima: la giurisprudenza qualifica come violenza qualsiasi comportamento che limiti la libertà della donna o la costringa a vivere in una condizione di paura, soggezione o sopraffazione.
In particolare, la legge definisce come violenza domestica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano:
- all’interno della famiglia o del nucleo familiare,
- oppure tra partner o ex partner, coniugi o ex coniugi, indipendentemente dal fatto che l’autore abbia mai convissuto con la vittima.
Per “vittima” si intende qualunque persona fisica che subisca questi atti o comportamenti, mentre per “donne” si includono le ragazze minorenni, quindi anche tutte le donne di età inferiore ai 18 anni.
Quali sono le differenze tra violenza sulle donne e violenza di genere?
La violenza di genere è un concetto ampio che comprende qualsiasi forma di violenza esercitata su una persona in ragione del suo genere o della sua identità di genere. Riguarda non solo le donne, ma anche uomini, persone LGBTQ+ e altri gruppi soggetti a discriminazioni legate al genere.
La violenza contro le donne è una categoria specifica all’interno della violenza di genere. Si riferisce a tutti gli atti di violenza che colpiscono le donne in quanto donne, provocando o rischiando di provocare danni fisici, sessuali, psicologici o economici, comprese le ragazze minorenni.
Spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi, poiché la maggior parte delle vittime di violenza di genere sono donne. Nonostante questo, la distinzione è importante per comprendere le cause, le caratteristiche e le modalità con cui si manifesta la violenza, e anche per orientare correttamente le politiche di prevenzione, protezione delle vittime e gli interventi giudiziari.

Secondo l’ISTAT, il 31,5% delle donne
in Italia, tra i 16 e i 70anni (6 milioni 788 mila),
ha subito nel corso della propria vita
una qualche forma di violenza fisica o sessuale.
Quali sono i tipi di violenza contro le donne?
Esistono diverse forme di violenza riconosciute dalla legge italiana e dagli organismi internazionali. Tutte compromettono la libertà, la salute e la dignità della donna. L’Italia riconosce esplicitamente la pluralità delle forme di violenza di genere, che tradizionalmente possono essere categorizzate in cinque gruppi.
Cos’è la violenza psicologica sulle donne?
La violenza psicologica è tra le più diffuse ma spesso la più nascosta, perché non lascia segni visibili. Consiste in manipolazioni emotive o aggressioni verbali che minano la stabilità mentale della donna. Si manifesta attraverso:
- umiliazioni e insulti ripetuti;
- minacce verbali e intimidazioni;
- isolamento sociale forzato;
- controllo ossessivo su ogni scelta quotidiana.
Secondo l’Istat, circa il 30% delle donne ha subìto almeno una volta violenza psicologica da un partner o ex partner. È una delle forme più subdole, perché logora l’autostima e può impedire alla vittima di reagire.
Cos’è la violenza fisica?
La violenza fisica è la forma più evidente, caratterizzata da aggressioni fisiche con o senza lesioni visibili. Può presentarsi come:
- percosse con schiaffi, calci, pugni, morsi;
- spintoni o strattoni;
- colpi con oggetti;
- strangolamenti o tentativi di soffocamento;
- minacce con armi.
La violenza fisica è tra le forme più riconoscibili di maltrattamento, spesso accompagnata da violenza psicologica o economica.
Cos’è la violenza sessuale?
La violenza sessuale comprende tutti gli atti sessuali imposti contro la volontà della donna. Si manifesta in vari modi:
- rapporti sessuali imposti con la forza o la minaccia;
- atti sessuali non consensuali;
- costrizione a pratiche sessuali indesiderate;
- molestie sessuali fisiche, come baci forzati.
Secondo la legge italiana, anche il partner o il coniuge possono essere responsabili di violenza sessuale. Lo stupro coniugale, ad esempio, è punito come qualsiasi altro abuso.
Cos’è la violenza economica?
La violenza economica si manifesta quando una donna viene privata o limitata nel suo accesso alle risorse economiche in diversi modi:
- controllo totale del denaro da parte del partner;
- impedire alla donna di lavorare o studiare;
- escludere la vittima dalla gestione del patrimonio familiare;
- concedere soldi “a piacere” come strumento di ricatto.
La violenza economica impedisce spesso alle vittime di lasciare situazioni violente.
Cos’è la violenza assistita?
Si parla di violenza assistita quando i figli assistono, direttamente o indirettamente, alla violenza subita dalla madre o da altre figure femminili di riferimento. Può manifestarsi con:
- esposizione a episodi di violenza fisica o psicologica in casa;
- assistenza forzata a liti violente tra adulti;
- percezione continua di paura o minaccia verso il genitore maltrattato.
La violenza assistita è una forma di maltrattamento minorile, che può avere conseguenze sullo sviluppo emotivo e sociale del minore nel breve, medio e lungo termine, e rappresenta uno dei fattori di rischio per la trasmissione intergenerazionale della violenza (Cismai).
Oltre a questo primo elenco di sopraffazioni, recentemente sono emerse nuove forme di violenza come quella digitale e lo stalking.
Cos’è la violenza digitale?
La violenza digitale riguarda ogni forma di abuso esercitato attraverso canali informatici. Si manifesta attraverso:
- diffusione non consensuale di immagini intime (revenge porn);
- controllo tramite app di localizzazione o spyware;
- molestie via messaggi, social media o email;
- minacce, umiliazioni o ricatti online.
La violenza digitale sta aumentando in modo esponenziale, sopratutto tra gli adolescenti. Per questo è stata inserita tra i reati previsti dal Codice Rosso.
Cos’è lo stalking?
Lo stalking è definito come una serie di atti persecutori ripetuti, capaci di generare ansia e costringere la vittima a cambiare abitudini come:
- pedinamenti e appostamenti;
- telefonate o messaggi continui e ossessivi;
- invio indesiderato di regali o lettere;
- controllo costante delle attività quotidiane;
- sorveglianza fisica o digitale.
Lo stalking è un reato riconosciuto dalla legge e punito severamente perché limita la libertà personale e condiziona pesantemente la vita della vittima.

Quali sono le leggi contro la violenza sulle donne?
In Italia la violenza sulle donne è regolata da un insieme di leggi specifiche che prevedono la tutela delle vittime e pene severe per gli autori di questo reato. Oltre alla Convenzione di Instanbul, le principali norme sono il Codice Rosso, la legge 66/1996 e la recente legge 168/2023.
Cos’è il Codice Rosso?
Il Codice Rosso è la legge n. 69 del 19 luglio 2019. È una norma che prevede procedure accelerate per proteggere rapidamente le vittime di violenza domestica e di genere.
Quando una denuncia di violenza arriva alla procura, le autorità hanno l’obbligo di ascoltare la vittima entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
La legge interviene anche con misure cautelari immediate, come l’allontanamento dell’aggressore e il divieto di avvicinamento.
Cosa prevede la legge italiana per il Codice Rosso?
Oltre ai tempi rapidi, il Codice Rosso ha introdotto nuovi reati e aggravato le pene per i crimini contro le donne. Tra le novità più importanti:
- Reato di sfregio al volto con pene da 8 a 14 anni;
- Reato di costrizione o induzione al matrimonio punito fino a 5 anni;
- Reato di revenge porn, cioè la diffusione non consensuale di immagini intime, con pene fino a 6 anni;
- Aggravamento delle pene per maltrattamenti, stalking e violenze sessuali.
Cosa prevede la legge 66/1996?
La legge 15 febbraio 1996, n. 66 ha introdotto il reato di violenza sessuale nel codice penale italiano. È una legge storica perché ha trasformato la violenza sessuale da semplice “delitto contro la morale” a delitto contro la persona.
Le principali disposizioni prevedono:
- condanna da 5 a 10 anni per chi compie atti sessuali senza consenso;
- aggravanti se il reato è commesso con violenza o su minori;
- possibilità per la vittima di costituirsi parte civile e ottenere risarcimento danni.
Cosa stabilisce la legge 168/2023?
La legge 168/2023, nota come legge “contro la violenza domestica e di genere”, è una delle normative più recenti. Ha introdotto ulteriori tutele:
- possibilità di attivare l’arresto in flagranza differita per reati di violenza;
- velocizzazione dei tempi processuali;
- rafforzamento dell’uso del braccialetto elettronico per chi viola le misure cautelari;
- nuove misure a favore della protezione dei figli delle vittime.
Si tratta di un passo importante per rafforzare l’efficacia del Codice Rosso e assicurare protezione più immediata a chi denuncia.
L’Italia dispone oggi di una rete di leggi sempre più ampia per tutelare le donne vittime di violenza, con attenzione crescente alla rapidità delle risposte istituzionali e alla protezione concreta delle vittime.

Il Codice Rosso obbliga
i pubblici ufficiali (medici, insegnanti, operatori)
a segnalare ogni possibile caso di violenza.
Come riconoscere i segnali di violenza?
Riconoscere i segnali di violenza è fondamentale per intervenire tempestivamente e rompere il ciclo degli abusi. La violenza sulle donne non sempre lascia segni visibili: molti segnali si manifestano con cambiamenti nel comportamento, nella salute mentale e nelle dinamiche relazionali. È importante conoscere questi indicatori, soprattutto per chi si trova accanto ad una possibile vittima.
Quali segnali fisici indicano violenza sulle donne?
I segnali fisici più evidenti sono:
- lividi o ferite frequenti, soprattutto in zone del corpo facilmente nascoste (braccia, schiena, gambe);
- cicatrici inspiegabili o segni di aggressioni ripetute;
- fratture, contusioni o ustioni senza una motivazione chiara;
- trascuratezza del proprio aspetto, perdita di peso improvvisa o cattive condizioni igieniche.
Molte donne non dichiarano apertamente la violenza fisica, ma medici e conoscenti possono imparare a riconoscere questi segnali.
Quali segnali psicologici indicano maltrattamento?
La violenza psicologica è più difficile da notare, ma lascia segni profondi:
- stato costante di ansia, paura o sottomissione;
- abbassamento dell’autostima, senso di colpa continuo;
- isolamento sociale, la donna evita amici e parenti;
- cambiamenti repentini di umore o episodi di depressione;
- difficoltà a prendere decisioni, atteggiamento remissivo verso il partner.
La condizione di una donna vittima di violenza può peggiorare nel tempo, soprattutto se la vittima non riceve supporto esterno.
Come capire se si è in una relazione violenza?
Capire di essere in una relazione violenta può richiedere un lungo percorso di riflessione, perché la violenza spesso inizia in modo graduale. Alcuni campanelli d’allarme tipici sono:
- il partner esercita controllo eccessivo: decide con chi puoi uscire, controlla il cellulare, limita la tua libertà;
- usa l’isolamento come arma: ti allontana dalla famiglia o dagli amici;
- svaluta i tuoi successi, ti offende o ti ridicolizza anche in pubblico;
- alterna fasi di aggressività a gesti “riparatori”, creando confusione emotiva;
- impone il proprio volere, anche nei rapporti sessuali o nella gestione economica.
Queste dinamiche sono tipiche della violenza psicologica e si inquadrano nei modelli riconosciuti anche dalla Convenzione di Istanbul come parte integrante della violenza domestica.
Cosa fare se sei vittima di violenza
Quando si subisce violenza, è fondamentale sapere che esistono percorsi di protezione e supporto accessibili a tutte le donne, indipendentemente dalla situazione familiare o sociale. Anche in assenza di prove evidenti, la legge italiana garantisce il diritto ad essere ascoltate e protette.
Cosa fare se subisci violenza?
Il primo passo è mettersi in sicurezza. Se ti trovi in pericolo immediato:
- chiama subito il 112 per richiedere un intervento urgente;
- puoi anche contattare il 1522, il numero nazionale antiviolenza attivo 24 ore su 24, gratuito e anonimo (1522 – Dipartimento Pari Opportunità).
Dove chiedere aiuto in caso di violenza sulle donne?
Se la violenza è ripetuta, puoi rivolgerti a diversi enti:
- Centri Antiviolenza: offrono ascolto, accoglienza, assistenza legale gratuita (lista centri antiviolenza D.i.Re).
- Forze dell’Ordine: Carabinieri e Polizia di Stato sono formati per intervenire in casi di violenza domestica e di genere.
- Servizi sociali comunali: in molti comuni esistono uffici dedicati alla tutela delle donne vittime di violenza.
- La Caramella Buona offre supporto legale e psicologico gratuito tramite il numero verde 800.311.960.
Posso denunciare senza prove?
Sì, non servono prove materiali per presentare denuncia. La tua testimonianza ha valore legale. Saranno poi gli inquirenti a raccogliere le prove durante le indagini. La legge prevede la possibilità di:
- richiedere misure cautelari come l’allontanamento dell’aggressore;
- accedere al Codice Rosso, che garantisce una procedura accelerata con ascolto della vittima entro 3 giorni.
Denunciare non significa affrontare tutto da sola. Esistono percorsi protetti, avvocati dedicati, psicologi e case rifugio per accompagnarti verso una vita libera dalla violenza.
È possibile restare anonimi quando si denuncia?
Sì, puoi fare una segnalazione anonima ai servizi sociali o contattare il 1522 senza rivelare la tua identità. Tuttavia, per l’avvio di un procedimento penale, è necessario presentare denuncia formale con i propri dati.
Se lavori in ambito scolastico, sanitario o sociale, la legge ti obbliga a segnalare qualsiasi situazione sospetta entro 24 ore.
La Polizia di Stato ha realizzato anche l’app YouPol
che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima,
con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.
YouPol offre anche la possibilità di nascondere l’attività svolta con l’app.

Come denunciare: procedura legale
Denunciare la violenza subita è un passo fondamentale per interrompere il ciclo degli abusi e accedere alle misure di protezione previste dalla legge italiana. Anche se può sembrare difficile, la legge offre strumenti concreti per proteggere chi denuncia e punire gli autori di violenza di genere.
Come denunciare la violenza sulle donne?
Puoi denunciare la violenza presentandoti in qualsiasi momento presso:
- in caso di pericolo imminente o emergenza chiamare il 112 (Numero unico) o il 113 (Polizia di Stato);
- una stazione dei Carabinieri o un ufficio della Polizia di Stato;
- chiamare il numero 1522 (Numero Anti Violenza e Stalking);
- la Procura della Repubblica, soprattutto presso il Tribunale per i Minorenni se ci sono figli coinvolti;
- o tramite un avvocato di fiducia.
La denuncia può essere verbale o scritta. Non servono formalità particolari: basta raccontare i fatti, anche senza prove materiali. Gli agenti hanno l’obbligo di raccogliere la tua dichiarazione e trasmetterla alla procura competente.
Quali prove servono per denunciare violenza?
Non è obbligatorio avere prove materiali per sporgere denuncia. La legge prevede che la semplice dichiarazione della vittima sia sufficiente ad avviare le indagini. Durante le indagini, gli inquirenti provvedono a:
- acquisire referti medici (se disponibili);
- raccogliere messaggi, e-mail, foto o video;
- ascoltare testimoni, vicini, colleghi, amici;
- richiedere perizie psicologiche quando utile.
La raccolta delle prove spetta alle autorità: non è mai richiesto che la vittima conduca da sola indagini o raccolte di documenti.
Cosa succede dopo aver fatto denuncia?
Una volta presentata denuncia:
- la Procura apre un’indagine penale;
- se la situazione è grave, può essere disposto l’allontanamento immediato dell’aggressore;
- viene attivato il Codice Rosso, che garantisce un ascolto rapido della vittima entro 3 giorni;
- possono essere applicate misure cautelari come divieto di avvicinamento o l’uso del braccialetto elettronico;
- se l’aggressore viola le misure imposte, scattano pene ulteriori.
Denunciare non significa essere lasciate sole. Dopo la denuncia, le istituzioni sono tenute a offrire tutela concreta, protezione immediata e accesso ai servizi di supporto.
Tempi e funzionamento del processo penale
Il processo penale per violenza sulle donne segue regole specifiche pensate per tutelare la vittima, evitare la vittimizzazione secondaria e garantire tempi rapidi nei casi più gravi. Come già visto, la legge italiana prevede procedure accelerate grazie al Codice Rosso, con l’obiettivo di assicurare giustizia senza ulteriori traumi.
Quanto dura il processo per violenza sulle donne?
La durata del processo dipende da vari fattori: la complessità del caso, il carico di lavoro del tribunale e l’eventuale presenza di procedimenti collegati (ad esempio per l’affidamento dei figli).
Con il Codice Rosso, i reati di violenza domestica e di genere devono avere una corsia preferenziale. La fase delle indagini preliminari inizia con l’ascolto rapido della vittima entro tre giorni dalla denuncia.
I tempi medi nei tribunali italiani possono variare:
- dalle indagini alla richiesta di rinvio a giudizio: circa 3-6 mesi;
- fase processuale: da 6 mesi a 2 anni per i procedimenti penali in primo grado;
- tempi più rapidi nei casi di flagranza o con gravi indizi di pericolo per la vittima.
Cosa succede nel processo con Codice Rosso?
Il Codice Rosso garantisce tempi più rapidi nelle indagini e nel processo:
- la vittima viene ascoltata immediatamente;
- l’imputato può essere sottoposto a misure cautelari già durante le indagini;
- i pubblici ufficiali sono obbligati a trasmettere tempestivamente la notizia di reato;
- il tribunale può disporre l’allontanamento dell’aggressore già prima dell’udienza preliminare.
L’obiettivo del Codice Rosso è evitare che la vittima resti esposta al rischio mentre il procedimento è in corso.
Cosa prevede l’allontanamento dell’autore?
In caso di pericolo per la vittima o i figli, il giudice può disporre:
- allontanamento d’urgenza dell’aggressore dalla casa familiare;
- divieto di avvicinamento alla vittima, anche nei luoghi frequentati abitualmente (scuola, lavoro);
- braccialetto elettronico per monitorare l’allontanamento;
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: l’autore della violenza è obbligato a presentarsi periodicamente presso un comando delle forze dell’ordine per garantire il controllo e la prevenzione di eventuali nuove violenze;
- divieto di dimora: impedisce all’aggressore di soggiornare o stabilirsi in un determinato Comune, area o luogo in cui risiede o frequenta la vittima;
- in caso di violazione delle misure, arresto immediato.
Queste misure possono essere attivate già durante le indagini preliminari, senza attendere la condanna definitiva.
Quando si può ottenere un risarcimento?
La vittima di violenza può chiedere il risarcimento danni:
- attraverso la costituzione di parte civile durante il processo penale;
- tramite causa civile autonoma;
- accedendo a fondi pubblici come il Fondo vittime di reati violenti e domestici.
Il risarcimento può coprire il danno biologico (fisico e psicologico), il danno morale, il danno esistenziale e le spese mediche.
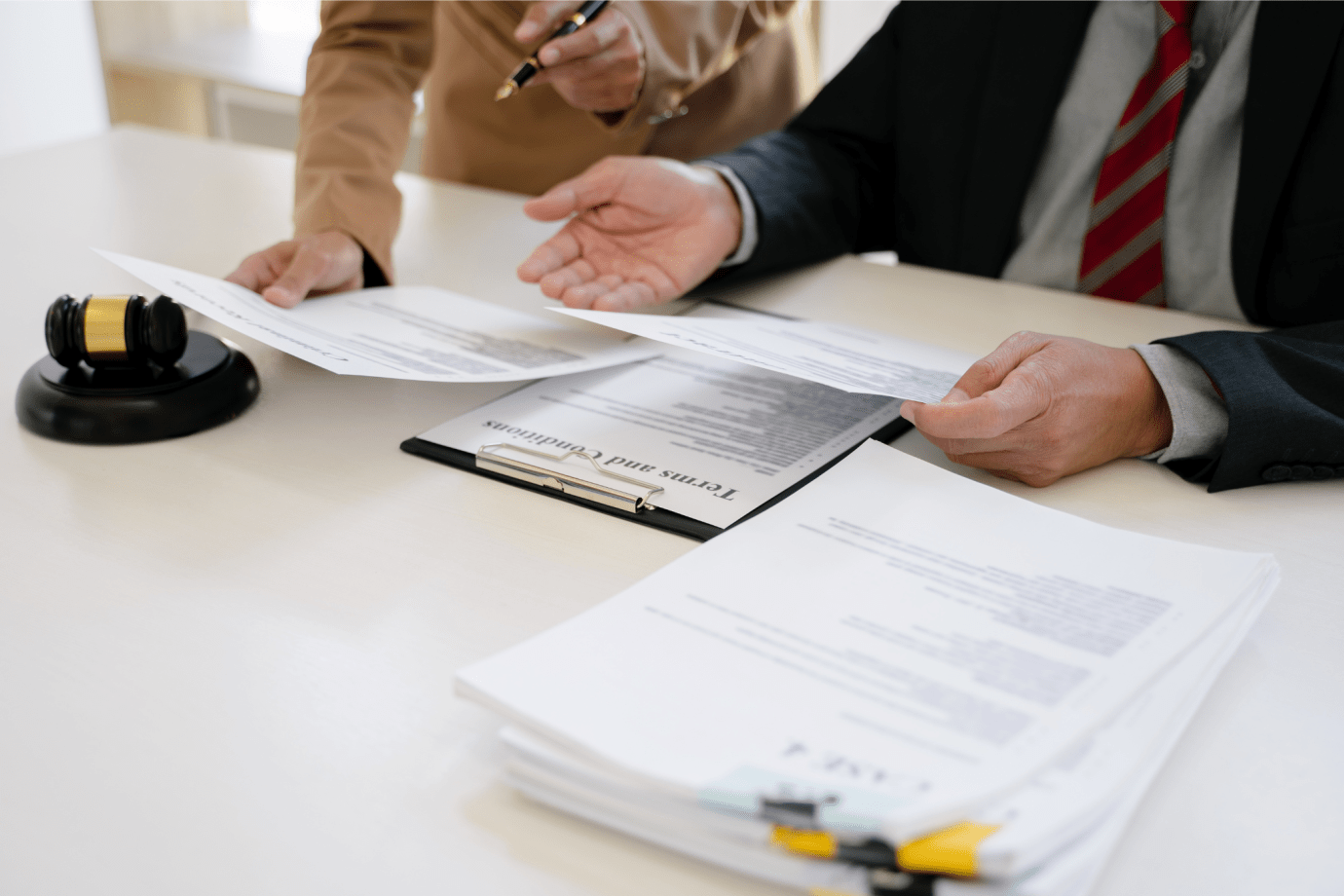
La Caramella Buona, in 28 anni di attività,
ha aiutato i propri assistiti ad ottenere
250 anni di carcere ed 1 ergastolo
contro sex offender e familiari violenti.
Supporto psicologico e legale per donne vittime
Dopo aver denunciato, è fondamentale ricevere supporto psicologico e legale adeguato. In Italia esistono reti di centri specializzati, servizi pubblici e associazioni che offrono assistenza gratuita o a basso costo.
Ricorda che non sei sola: ci sono strumenti concreti per aiutarti a superare il trauma e affrontare le procedure giudiziarie con il sostegno necessario.
Dove trovare supporto psicologico gratuito?
Puoi accedere a supporto psicologico tramite:
- Centri Antiviolenza, che offrono percorsi gratuiti di ascolto, sostegno emotivo e terapia psicologica;
- ASL e consultori familiari, che forniscono psicoterapia gratuita o con ticket ridotto;
- Sportelli Codice Rosa negli ospedali, dedicati a vittime di violenza con personale formato;
Posso avere un avvocato gratuito per denunciare?
Sì. Se sei vittima di violenza puoi accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, indipendentemente dal tuo reddito, nei procedimenti penali relativi a:
- maltrattamenti;
- violenza sessuale;
- stalking;
- violenza domestica.
Puoi chiedere un avvocato di tua fiducia o farti assistere dagli avvocati messi a disposizione dai centri antiviolenza o da associazioni come La Caramella Buona.
Esistono centri antiviolenza vicino a me?
In Italia esistono oltre 350 Centri Antiviolenza, distribuiti in tutte le regioni. Offrono gratuitamente:
- accoglienza;
- supporto legale;
- sostegno psicologico;
- ospitalità in case rifugio.
Per trovare quello più vicino puoi:
- chiamare il 1522 che fornisce indicazioni immediate;
- consultare la lista aggiornata di D.i.Re;
- contattare La Caramella Buona che collabora con reti territoriali nazionali.
Non devi affrontare la violenza da sola: in ogni provincia ci sono operatori, psicologi e avvocati pronti ad aiutarti.
Prevenzione e sensibilizzazione
La prevenzione è il mezzo più efficace per contrastare la violenza sulle donne e la violenza di genere. Prevenire significa lavorare ogni giorno per costruire maggiore consapevolezza delle dinamiche di una relazione sana e una cultura del rispetto tra persone. Esistono campagne pubbliche, percorsi educativi e iniziative simboliche che aiutano a mantenere alta l’attenzione su questo tema.
Come prevenire la violenza sulle donne?
La prevenzione passa da piccole azioni quotidiane:
- educare al rispetto reciproco fin da piccoli;
- non giustificare mai la violenza, nemmeno verbale;
- intervenire come testimoni attivi quando si assiste a situazioni di abuso;
- sostenere le donne che manifestano disagio o paura;
- promuovere ambienti di lavoro sicuri e rispettosi.
Il Dipartimento per le Pari Opportunità promuove campagne informative e sostiene progetti educativi in scuole e territori locali.
Un impegno concreto per la prevenzione e la protezione
Anche La Caramella Buona si impegna ogni giorno per costruire una cultura del rispetto e della prevenzione attraverso:
- incontri nelle scuole, per aiutare gli studenti a riconoscere le relazioni violente, imparare il rispetto reciproco e sapere a chi rivolgersi in caso di difficoltà;
- spettacoli teatrali, per sensibilizzare la società civile contro la violenza sulle donne e promuovere un cambiamento culturale positivo;
- progetti formativi, rivolti a educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari per migliorare la capacità di riconoscere la violenza e intervenire in modo efficace.
Prevenire la violenza è possibile, soprattutto quando si lavora insieme: sostenere le donne in difficoltà, formare in modo adeguato a chi lavora con loro e intervenire tempestivamente sono gesti concreti che possono salvare una vita.