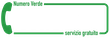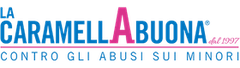In Italia ogni anno quasi 114.000 minori sono vittime di abuso o maltrattamento, e nell’87% dei casi il responsabile è una persona della cerchia familiare, come riportato dall’ultima indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti.
Queste cifre raccontano un fenomeno che non può essere trascurato. È fondamentale che chi si trova vicino ad un minore in difficoltà — genitori, insegnanti, educatori, amici — sappia riconoscere i segnali di violenza e possa fornire un primo livello di assistenza.
Per questo, noi de La Caramella Buona abbiamo realizzato questa guida: un aiuto pratico per chi subisce violenza e per chi si trova di fronte ad un sospetto di abuso su minore.
Nota importante: questa guida ha solo scopo informativo. In caso di pericolo o emergenza, contatta immediatamente le forze dell’ordine, i servizi sociali o i numeri pubblici di emergenza.
Indice dei contenuti
- Cos’è l’abuso su minore?
- Come riconoscere i segnali di abuso su minore
- Cosa fare se sospetti un abuso su minore
- Se sei stato vittima: cosa puoi fare oggi
- La denuncia per abuso su minore: come funziona in Italia
- L’ascolto e la testimonianza del minore: come avviene in Italia
- Processo penale per abuso su minore: come funziona
- Maltrattamenti in famiglia: cosa dice la legge italiana
- Prevenzione e protezione dei minori: cosa fare per evitare l’abuso
- Se sei un minore vittima di abusi, contattaci!
Cos’è l’abuso su minore?
L’abuso su minore è un fenomeno complesso che comprende diverse forme di violenza, non solo fisica o sessuale, ma anche psicologica, affettiva ed educativa. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’abuso infantile si verifica ogni volta che un adulto causa danni reali o potenziali alla salute, allo sviluppo o alla dignità di un bambino, approfittando di una posizione di responsabilità, fiducia o potere. Si parla, quindi, di abuso quando un minore subisce sofferenze fisiche, traumi psicologici, sfruttamento sessuale, trascuratezza o viene coinvolto in situazioni pericolose senza poterle riconoscere o evitare.
Dal punto di vista pratico, si considera abuso qualsiasi comportamento o omissione che impedisce al bambino di crescere serenamente, compromettendo il suo benessere fisico, emotivo e relazionale.
Quali sono i tipi di abuso: fisico, sessuale, psicologico, trascuratezza?
Ci sono diverse forme di abuso riconosciute dalla legge italiana. Le più frequenti sono:
- Abuso fisico: quando un adulto colpisce, scuote, o fa male fisicamente a un minore, provocando lividi, fratture o altre lesioni.
- Abuso sessuale: qualunque atto o contatto sessuale verso un minore, anche senza violenza fisica. È sempre un reato, anche se il minore non si oppone.
- Abuso psicologico: offese ripetute, umiliazioni, isolamento forzato o minacce continue che distruggono la sicurezza emotiva del bambino.
- Trascuratezza (o neglect): quando il minore viene abbandonato, non viene curato, alimentato, o non riceve supporto educativo adeguato.
Secondo i dati nazionali più aggiornati, la trascuratezza è la forma più diffusa di abuso in Italia (37% dei casi), seguita dalla violenza assistita (34%), dalla violenza psicologica (12%), dal maltrattamento fisico (11%) e dall’abuso sessuale (2%).
Qual è la differenza tra abuso e maltrattamento?
La parola “abuso” si usa spesso per indicare azioni gravi e specifiche come la violenza sessuale o le percosse. Il “maltrattamento” è un concetto più ampio e riguarda situazioni in cui il minore vive in un ambiente nocivo in modo continuativo. Ad esempio, vivere in una famiglia dove sono presenti continue urla, umiliazioni o trascuratezza cronica può essere considerato maltrattamento, anche se non ci sono episodi singoli di violenza fisica.
In pratica, l’abuso riguarda atti precisi, mentre il maltrattamento può essere fatto di continue umiliazioni e sopraffazioni.
La definizione legale di abuso e maltrattamento su minore
Dal punto di vista normativo, in Italia non esiste un unico articolo che definisca in modo generale “l’abuso infantile”, ma esistono diverse leggi che puniscono le varie forme di abuso. La normativa si concentra soprattutto sulla tutela del minore da violenze fisiche, psicologiche e sessuali.
Per quanto riguarda gli abusi sessuali, la legge principale è la Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha riformato profondamente il codice penale. I riferimenti più importanti sono:
- Articolo 609-bis c.p. → punisce la violenza sessuale, compresa quella commessa su minore, anche in assenza di violenza fisica, quando c’è abuso di autorità o inganno.
- Articolo 609-quater c.p. → punisce gli atti sessuali con minori di 14 anni (sempre considerati non consenzienti) o tra 14 e 16 anni se l’adulto è un genitore o una figura di responsabilità.
- Articolo 609-undecies c.p. → punisce l’adescamento di minori, anche online.
In merito ai maltrattamenti, la norma di riferimento è l’Articolo 572 del codice penale, che punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente, compreso il minore. La pena parte da 3 anni fino a 7 anni, aggravata se il maltrattamento riguarda minori.
Esistono poi norme complementari:
- La Legge 269/1998 per contrastare lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.
- La Convenzione di Lanzarote (ratificata in Italia con la Legge 172/2012) che rafforza la protezione dei minori dagli abusi sessuali.
- La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (Legge 176/1991) che impone agli Stati di tutelare i bambini da ogni forma di violenza.
Dal punto di vista civile, l’articolo 403 del codice civile consente, inoltre, alle autorità di allontanare immediatamente un minore da situazioni pericolose.
Quando un comportamento è da considerarsi abuso?
Non serve che il bambino mostri lividi o segni evidenti per parlare di abuso. Qualunque situazione in cui un adulto usa il proprio potere per dominare, umiliare o sfruttare un minore può essere considerata abuso. Conta molto l’effetto sulla salute psicofisica del bambino.
Secondo la legge italiana, anche costringere un minore ad assistere a scene di violenza domestica può essere considerato abuso, così come utilizzare il bambino per ricatti tra adulti.
L’abuso su minore non è, quindi, solo riferito alla violenza fisica, ma comprende tante situazioni che mettono in pericolo la serenità, la crescita e la dignità dei più piccoli.
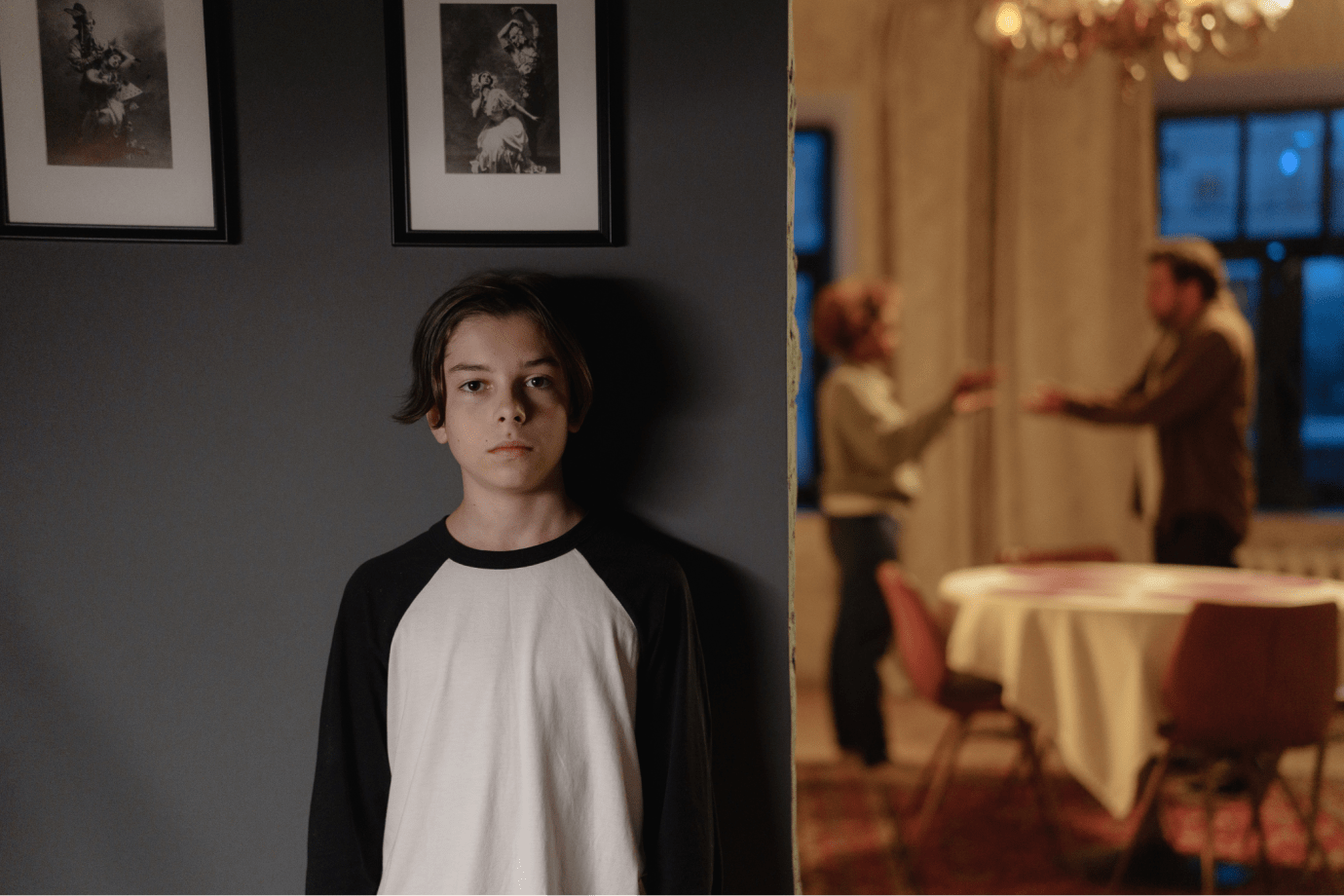
Per tenerti aggiornato puoi consultare anche
il sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e
Come riconoscere i segnali di abuso su minore
Un bambino non sempre riesce a chiedere aiuto con le parole. Spesso i segnali di abuso sono rivelati da comportamenti insoliti o da segni fisici. Imparare a riconoscere questi segnali può fare davvero la differenza, perché permette di intervenire in tempo e proteggere il minore.
Quali sono i segnali fisici, psicologici e comportamentali nei bambini?
I segnali fisici più comuni includono lividi in zone insolite (interno cosce, schiena), fratture ripetute, bruciature o graffi inspiegabili. Un altro segnale da non sottovalutare è la trascuratezza evidente: cattiva igiene, malnutrizione o vestiti non adatti alla stagione.
Dal punto di vista psicologico, le vittime di abuso possono mostrare:
- isolamento sociale;
- comportamenti regressivi (ad esempio, tornare a fare pipì a letto);
- paure improvvise e immotivate;
- tristezza o sbalzi d’umore frequenti.
Nei comportamenti osservabili ci possono essere esplosioni di rabbia, aggressività insolita, comportamenti sessualizzati inappropriati per l’età o difficoltà scolastiche improvvise.
Questi segnali non sono sempre prova certa di abuso, ma quando compaiono più indizi contemporaneamente è importante non sottovalutarli.
Quali sono i segnali indiretti nei contesti scolastici o sportivi?
Scuole e ambienti sportivi sono spesso i primi luoghi dove gli adulti esterni alla famiglia possono notare qualcosa di strano. I segnali indiretti possono includere:
- Calano improvvisamente i risultati scolastici o il bambino appare disinteressato alle lezioni;
- Frequenti assenze non giustificate o richieste continue di andare in bagno;
- Paura o disagio verso determinate persone adulte;
- Racconti confusi o incoerenti su cosa succede a casa;
- Eccessiva aggressività o, al contrario, totale passività nei confronti degli altri bambini.
Gli insegnanti dovrebbero fare attenzione anche a bambini sempre stanchi, poco reattivi, o eccessivamente timorosi nei confronti di adulti in posizione di autorità.
Quando preoccuparsi e cosa osservare?
Un campanello d’allarme deve sempre suonare quando un bambino mostra un cambiamento radicale nel suo comportamento, senza cause apparenti. È importante osservare:
- Durata del comportamento anomalo: se continua per settimane o mesi;
- Frequenza: più si ripete, maggiore è il rischio;
- Coinvolgimento emotivo: quando un bambino appare particolarmente provato o in ansia.
Quando ci sono più segnali che coincidono, è sempre meglio segnalare ai servizi competenti. Non è dovere dei cittadini “verificare”, ma proteggere il minore dando l’allarme.
Cosa fare se si notano questi segnali?
Il passo giusto non è mai quello di interrogare il bambino o affrontare direttamente il sospettato. È preferibile:
- Raccogliere le proprie osservazioni con attenzione, meglio se per iscritto;
- Non fare domande pressanti o suggestive al minore;
- Rivolgersi subito ai servizi competenti, come i servizi sociali, le forze dell’ordine, il 114 Emergenza Infanzia o il numero verde 800.311.960 de La Caramella Buona.
Imparare a riconoscere i segnali di abuso non significa fare indagini personali, ma saper leggere comportamenti insoliti per poi affidarsi a chi ha gli strumenti per intervenire.
Alcune linee guide molto utili sono fornite, ad esempio,
dal protocollo d’intesa sulle modalità di segnalazione
della provincia di Trento, che spiega come
il personale scolastico dovrebbe intervenire in questi casi.

Cosa fare se sospetti un abuso su minore
Se hai anche solo il sospetto che un bambino stia subendo un abuso, non sottovalutarlo. La legge italiana prevede precisi obblighi di segnalazione e offre diversi strumenti per intervenire rapidamente. Non occorrono prove certe per agire: il principio guida è la tutela del minore.
A chi rivolgersi in caso di sospetto abuso?
In Italia ci sono diversi enti a cui puoi rivolgerti:
- Forze dell’Ordine puoi rivolgerti direttamente a Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale.
- Servizi Sociali Tutela Minori, presenti in ogni comune, si occupano di ricevere le segnalazioni e valutare la situazione.
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni gestisce i procedimenti giudiziari per la tutela dei minori.
- Centri Antiviolenza offrono supporto psicologico e legale, spesso anche accoglienza in emergenza.
- 114 Emergenza Infanzia è un numero gratuito attivo 24 ore su 24 per segnalare situazioni di pericolo anche in forma anonima.
- La Caramella Buona al numero verde 800.311.960 o tramite la pagina contatti.
Quando segnalare un sospetto abuso, anche senza prove?
La legge non richiede di avere prove certe prima di segnalare. È sufficiente un ragionevole dubbio, basato su osservazioni dirette o racconti del minore. Soprattutto insegnanti, medici, allenatori e altri pubblici ufficiali hanno l’obbligo di riferire qualsiasi sospetto entro 24 ore.
Segnalare non significa accusare nessuno, ma permettere agli enti competenti di valutare la situazione. Le indagini spettano esclusivamente alle autorità: nessuno deve interrogare il minore o cercare conferme da solo.
Posso fare una segnalazione anonima?
Il cittadino comune può scegliere di segnalare in forma anonima, soprattutto attraverso i numeri verdi o inviando segnalazioni ai servizi sociali. Tuttavia, chi lavora come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ad esempio insegnanti o medici) non può essere anonimo, perché ha l’obbligo di segnalare formalmente.
Una segnalazione anonima può comunque dare il via a controlli da parte degli assistenti sociali, anche se non sempre porta immediatamente a un intervento.
Quando si parla di obbligo di denuncia?
L’obbligo di denuncia scatta per tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio quando vengono a conoscenza di un reato (art. 331 c.p.p.) Per i privati cittadini non c’è obbligo formale, ma la legge riconosce comunque la responsabilità morale e civile di intervenire per proteggere un minore.
In alcuni casi — come maltrattamenti in famiglia, abusi sessuali o sfruttamento di minori — la legge italiana prevede la procedibilità d’ufficio: ciò significa che le autorità sono tenute ad agire indipendentemente dalla denuncia o dalla volontà della vittima.
Se sei stato vittima: cosa puoi fare oggi
Non è mai troppo tardi per denunciare un abuso subito da bambino. Anche se sono passati anni, in Italia la legge offre strumenti per tutelare chi ha vissuto esperienze traumatiche durante l’infanzia. Esistono percorsi legali e psicologici dedicati a chi decide di parlare solo da adulto.
È possibile denunciare da adulto? Come funziona la prescrizione?
Sì, puoi denunciare un abuso anche dopo molti anni. La legge italiana ha introdotto negli ultimi anni importanti modifiche sui termini di prescrizione per i reati su minori. In particolare, con la legge 172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote) il termine di prescrizione per alcuni reati gravi (come violenza sessuale) inizia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno del minore.
Per i reati più gravi, come abuso sessuale aggravato o violenza assistita, i tempi di prescrizione sono più lunghi o addirittura sospesi nei casi più estremi. Questo significa che anche un adulto che ha subito abuso da bambino può ottenere giustizia, soprattutto se il reato rientra nelle categorie più gravi.
Per chiarire la propria situazione specifica è sempre consigliabile rivolgersi a un centro antiviolenza, a un avvocato esperto oppure richiedere una prima consultazione gratuita attraverso i servizi legali di La Caramella Buona.
Come funziona il risarcimento danni per chi è stato vittima di abuso?
Sì, chi ha subito abusi durante l’infanzia ha diritto a chiedere un risarcimento danni nei confronti dell’autore del reato. Questo può avvenire:
- tramite una causa civile autonoma;
- oppure costituendosi parte civile nel processo penale contro l’abusante.
In alcuni casi si può accedere anche a fondi pubblici di indennizzo previsti per vittime di reati violenti, soprattutto se il responsabile non è in grado di risarcire.
Il risarcimento può coprire:
- il danno biologico (fisico o psicologico),
- il danno morale,
- e il danno esistenziale, quando il trauma ha compromesso il percorso di vita della persona.
La valutazione del danno viene effettuata da specialisti nominati dal giudice.
Dove trovare supporto psicologico in Italia?
Accanto alla tutela legale, esistono percorsi psicologici specializzati per adulti che hanno subito violenze da minori. È possibile rivolgersi a:
- Centri Antiviolenza, presenti in quasi tutte le città, che offrono ascolto e primo supporto gratuito;
- Servizi Sociali per la Tutela dei Minori, che possono seguire situazioni di adulti con traumi legati a contesti familiari violenti ancora attuali;
- Servizi sanitari territoriali (ASL), che in molte regioni prevedono sportelli dedicati e accesso a percorsi di psicoterapia anche gratuita.
La terapia non cancella il passato, ma può aiutarti a ridurre il senso di colpa, affrontare il trauma e migliorare la qualità della tua vita.
Anche La Caramella Buona supporta le vittime con percorsi di assistenza psicologica, aiutando le persone a ritrovare serenità e ricostruire fiducia in se stesse.
Anche da adulto puoi quindi agire, ottenere giustizia e ricevere supporto. Non importa quanto tempo sia passato: la legge prevede strumenti concreti per tutelarti e aiutarti a ricominciare con un supporto adeguato.
La denuncia per abuso su minore: come funziona in Italia
Quando si scopre o si sospetta un caso di abuso su minore, denunciare è un passo necessario per proteggere il bambino e avviare il procedimento penale contro chi ha commesso il reato. Vediamo come funziona in concreto la denuncia in Italia, a chi rivolgersi e cosa aspettarsi dopo aver fatto la segnalazione.
Come si fa la denuncia? Dove si presenta?
La denuncia può essere presentata:
- presso qualsiasi comando di Carabinieri o Polizia di Stato;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- tramite i Servizi Sociali del comune di residenza;
- oppure contattando il 114 Emergenza Infanzia, che attiva immediatamente i servizi competenti.
Non serve un avvocato per fare denuncia. Chiunque può presentarla, anche con una semplice dichiarazione scritta, indicando i fatti osservati o le informazioni ricevute. L’importante è che la segnalazione sia chiara, con informazioni concrete.

Se sei un insegnante, medico, assistente sociale
o altro pubblico ufficiale, hai l’obbligo legale di denunciare
entro 24 ore da quando vieni a conoscenza di
un possibile caso di abuso minorile.
Cosa succede dopo la denuncia?
Dopo aver ricevuto la denuncia, l’autorità competente apre un fascicolo d’indagine. Solitamente la Procura per i Minorenni attiva subito il servizio sociale per una prima verifica delle condizioni del bambino. Nei casi urgenti, si procede con misure immediate di protezione, come previsto dall’articolo 403 del Codice Civile, che permette l’allontanamento urgente del minore da situazioni pericolose.
L’indagine può includere:
- l’ascolto protetto del minore, sempre svolto da personale qualificato in modo non traumatico;
- visite mediche specialistiche;
- la raccolta di documenti, messaggi, fotografie o altre prove digitali;
- l’interrogatorio di testimoni.
Nei casi più gravi può essere disposto l’incidente probatorio, cioè un ascolto giudiziale del minore prima del processo, per evitare ulteriori traumi.
Quali prove servono per avviare un’indagine?
Non è necessario avere prove materiali per fare denuncia. Le indagini vengono avviate anche con semplici dichiarazioni o segnalazioni, specie nei reati perseguibili d’ufficio come maltrattamenti o abusi sessuali. Ovviamente, se hai documenti, foto, audio, referti medici o messaggi da allegare alla denuncia, è utile consegnarli.
Quali sono i rischi di denuncia falsa o calunniosa?
Fare una denuncia falsa consapevolmente è un reato (art. 368 codice penale – calunnia) e viene punito con pene severe. Ma se si agisce in buona fede, anche se il reato non viene poi confermato, non si rischia nulla. La legge tutela chi segnala un sospetto onesto, proprio per favorire l’intervento precoce nei casi di abuso.
Non serve essere sicuri al 100% per denunciare. Se il sospetto è ragionevole, vale sempre la pena segnalare. Meglio un accertamento in più che lasciare un minore in pericolo.
Il compito di raccogliere prove spetta agli investigatori.
I cittadini non devono mai indagare in modo autonomo,
anche per non inquinare le prove.

L’ascolto e la testimonianza del minore: come avviene in Italia
Ascoltare correttamente un minore vittima di abuso è un passaggio delicato. L’obiettivo principale è proteggere il bambino da ulteriori traumi e ottenere informazioni utili senza influenzarne i ricordi. Per questo la legge italiana prevede regole precise e modalità protette di ascolto durante le indagini e il processo.
Come funziona l’audizione protetta?
L’audizione protetta viene svolta in luoghi dedicati, spesso all’interno di ambienti protetti dei tribunali per i minorenni o in apposite stanze d’ascolto nei centri specializzati. È sempre condotta da professionisti preparati: psicologi forensi o esperti in psicologia infantile.
Durante l’audizione il minore non viene mai ascoltato direttamente dal giudice o dall’avvocato, ma da un esperto incaricato. Le domande vengono formulate in modo semplice, evitando ogni tipo di pressione o condizionamento.
Il procedimento segue quanto previsto dalla Carta di Noto, un protocollo italiano che stabilisce le regole di ascolto per tutelare il benessere del minore ed evitare di influenzarlo.
Testimonianza diretta o incidente probatorio?
Per evitare che il bambino debba ripetere la propria testimonianza più volte, in Italia si utilizza lo strumento dell’incidente probatorio. Si tratta di un ascolto anticipato rispetto al processo vero e proprio, svolto durante le indagini preliminari alla presenza di un giudice.
Il vantaggio è duplice:
- il minore viene ascoltato una sola volta, in modo protetto;
- la testimonianza acquisita ha pieno valore legale, evitando la necessità di ulteriori audizioni durante il processo.
Se per qualche motivo non viene svolto l’incidente probatorio, l’ascolto avviene comunque in modalità protetta, ma si cerca sempre di limitare al massimo le esposizioni a stress giudiziari.
Cosa sono le domande suggestive e come evitarle?
Le domande suggestive sono quelle che orientano il bambino verso una risposta (“ti ha toccato lì, vero?”) o fanno intuire l’aspettativa dell’adulto. La legge vieta rigorosamente questo tipo di domande, perché possono alterare i ricordi del bambino.
Durante le audizioni protette vengono utilizzate solo domande aperte, che lasciano il minore libero di raccontare senza condizionamenti (“puoi raccontarmi cos’è successo?”). Gli operatori sono formati per evitare frasi fuorvianti, gesti di approvazione o qualsiasi pressione.
Cos’è la Carta di Noto e perché è importante?
La Carta di Noto è un documento nato da un gruppo di magistrati, psicologi e avvocati italiani per stabilire buone prassi nell’ascolto del minore vittima di abuso. L’ultima versione aggiornata (Carta di Noto IV) stabilisce che:
- il minore deve essere ascoltato solo quando necessario;
- il numero di audizioni deve essere ridotto al minimo;
- l’audizione va sempre registrata;
- l’audizione deve essere sempre gestita da operatori con formazione specialistica.
Il suo scopo è evitare la “vittimizzazione secondaria”, ossia i danni psicologici che possono derivare da ascolti mal gestiti o ripetuti.
Per riassume, la legge italiana prevede che il minore venga ascoltato una sola volta, in ambienti protetti, con linguaggio adatto alla sua età. Strumenti come la Carta di Noto e l’incidente probatorio garantiscono l’acquisizione di informazioni, limitando il rischio di ulteriori traumi.
Processo penale per abuso su minore: come funziona
Quando un caso di abuso su minore arriva davanti alla giustizia, si apre un procedimento penale. È un percorso che può richiedere diversi mesi o anche anni, a seconda della complessità del caso. Conoscere le tappe principali del processo aiuta a capire cosa succede e quali pene prevede la legge italiana per chi commette reati contro i minori.
Quali sono i tempi e le fasi del procedimento?
Il procedimento penale segue queste fasi principali:
- Indagini preliminari: la Procura raccoglie prove, ascolta il minore in forma protetta, interroga testimoni e può richiedere perizie psicologiche o mediche.
- Rinvio a giudizio: se il pubblico ministero ritiene che ci siano elementi sufficienti, chiede il rinvio a giudizio e si apre il processo vero e proprio.
- Processo penale: il giudice valuta le prove, ascolta consulenti tecnici, periti e decide sulla colpevolezza dell’imputato.
Nei casi di reati contro minori, spesso viene utilizzata la procedura dell’incidente probatorio, così il minore non deve essere presente in aula al processo.
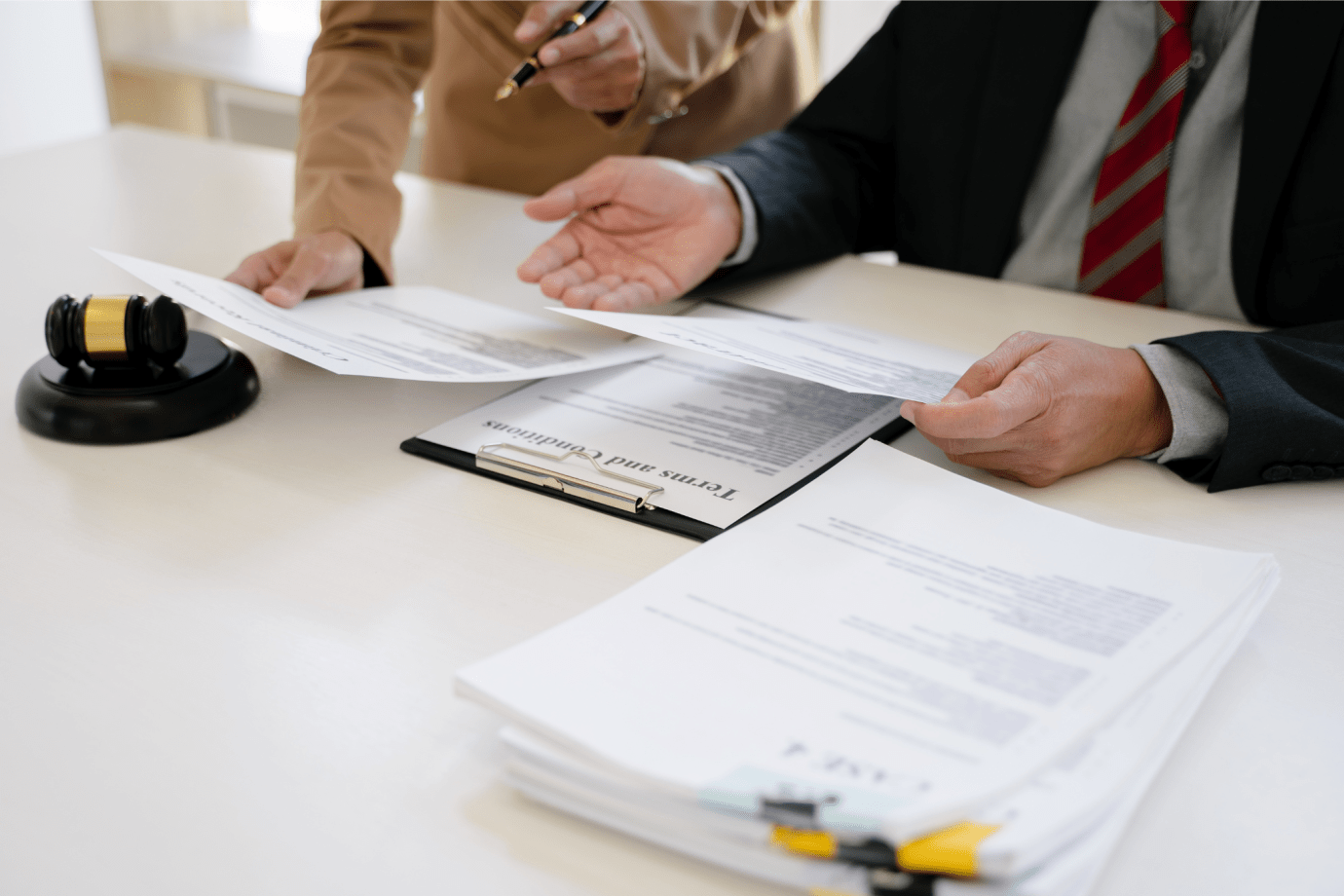
I tempi della procedura dipendono dalla gravità del caso,
ma grazie al Codice Rosso i procedimenti per reati contro minori
devono avere una corsia preferenziale e tempi più rapidi.
Quando intervengono avvocati e periti?
L’indagato ha diritto a farsi assistere da un avvocato in ogni fase. Anche la vittima (o chi la rappresenta) può nominare un avvocato di parte civile per chiedere il risarcimento danni durante il processo.
Durante il procedimento intervengono spesso:
- Periti psicologi o medici legali per valutare le condizioni del minore;
- Consulenti tecnici di parte che possono essere nominati dagli avvocati;
- Servizi sociali, che forniscono relazioni sul contesto familiare del bambino.
In alcuni casi il tribunale nomina un tutore speciale per il minore.
Quali sono le differenze tra abuso semplice e aggravato?
Il codice penale distingue tra abusi “semplici” o “aggravati”. L’aggravante più comune riguarda la minore età della vittima:
- Età della vittima: se il bambino ha meno di 14 anni, le pene sono più severe.
- Relazione con l’autore del reato: se l’abuso è commesso da un genitore, tutore o persona con potere sul minore, la pena aumenta.
- Modalità del reato: uso di minacce, violenza, droghe o armi comporta un ulteriore aggravamento.
Ad esempio, l’articolo 609-ter del codice penale prevede pene da 6 a 12 anni se l’abuso sessuale è aggravato dalla posizione dell’autore o dall’età della vittima.
Quali condanne e pene prevede il codice penale?
Per i reati più gravi contro i minori la legge prevede pene molto severe:
- Violenza sessuale semplice: da 5 a 10 anni (art. 609-bis c.p.).
- Violenza sessuale aggravata: da 6 a 12 anni o più (art. 609-ter c.p.).
- Atti sessuali con minorenne: da 5 a 10 anni o più in caso di aggravanti (art. 609-quater c.p.).
- Maltrattamenti in famiglia: da 3 a 7 anni, aumentabili se la vittima è un minore (art. 572 c.p.).
Oltre alle pene detentive, il tribunale può applicare anche pene accessorie, come:
- perdita della responsabilità genitoriale;
- interdizione dai pubblici uffici;
- divieto di svolgere attività a contatto con minori.
Quando non si configura reato?
Può accadere che durante il processo si accerti che:
- il fatto non è mai avvenuto;
- il minore ha subito un danno ma non da una condotta penalmente rilevante;
- ci siano errori di identificazione dell’autore.
In questi casi l’imputato viene assolto. È per questo che la legge richiede indagini accurate e testimonianze protette per garantire la correttezza del giudizio.
In breve: il processo penale per abuso su minore è regolato da norme stringenti, tempi accelerati e tutele specifiche per la vittima. L’obiettivo è garantire giustizia tutelando il minore da ulteriori traumi.
Maltrattamenti in famiglia: cosa dice la legge italiana
In Italia il maltrattamento in famiglia è un reato ben distinto rispetto all’abuso sessuale o fisico su minore, ma altrettanto grave. Viene punito dall’articolo 572 del codice penale, che tutela chiunque venga sottoposto a violenze fisiche o psicologiche nell’ambito familiare o convivente, compresi naturalmente i minori.
Qual è la differenza tra maltrattamenti e abuso?
La principale differenza è che il maltrattamento riguarda un comportamento continuativo e sistematico nel tempo. Non basta un singolo episodio: il maltrattamento si configura quando una persona sottopone il minore a sofferenze ripetute, che possono essere fisiche, morali o psicologiche.
L’abuso, invece, può riferirsi anche a un singolo atto particolarmente grave, come una violenza sessuale o un’aggressione fisica. Inoltre, il maltrattamento può avvenire senza contatto fisico, ad esempio con umiliazioni costanti, minacce, isolamento, e altre forme di violenza psicologica.
Come si dimostra il maltrattamento familiare?
La legge permette di dimostrare il maltrattamento attraverso:
- testimonianze di familiari, vicini, insegnanti;
- relazioni dei servizi sociali;
- referti medici che documentano lesioni, anche pregresse;
- verbali scolastici che segnalano cambiamenti nel comportamento del minore;
- registrazioni audio o video in alcuni casi.
Non servono sempre prove fisiche evidenti: anche comportamenti ripetuti di umiliazione o trascuratezza possono portare a condanna.
Cosa succede in caso di Codice Rosso?
Il Codice Rosso è stato introdotto in Italia con la legge n. 69/2019 per velocizzare le indagini nei reati familiari, compresi i maltrattamenti su minore.
Se un minore segnala o viene individuato come vittima di maltrattamenti, la procedura del Codice Rosso prevede:
- l’audizione obbligatoria della vittima entro 3 giorni dall’apertura del fascicolo;
- la valutazione immediata da parte della Procura;
- l’attivazione di misure cautelari rapide, come l’allontanamento del responsabile;
- la priorità assoluta nella trattazione del caso, così da ridurre il tempo in cui il minore rimane esposto a situazioni di rischio.
In questo modo, si riduce drasticamente il tempo in cui il minore resta esposto a rischio.
Quali sono tempi e condizioni per la denuncia?
Il maltrattamento è un reato procedibile d’ufficio: questo significa che una volta che l’autorità viene a conoscenza del fatto (attraverso denuncia, segnalazione scolastica, referto medico), ha l’obbligo di avviare le indagini anche senza la volontà della vittima o della famiglia.
Il reato di maltrattamenti prevede pene da 3 a 7 anni, aumentabili fino alla metà se la vittima è un minore. Anche senza prove evidenti, le indagini devono partire e possono portare alla protezione immediata del bambino.
Chiunque può denunciare, anche in forma anonima attraverso i numeri di emergenza come il 114 Infanzia
o contattando La Caramella Buona al numero verde 800.311.960.
Prevenzione e protezione dei minori: cosa fare per evitare l’abuso
La prevenzione è lo strumento più importante per ridurre il rischio di abusi sui minori. Significa agire prima che il danno avvenga, creando intorno ai bambini un ambiente sicuro, informato e attento. In Italia esistono programmi di prevenzione, linee guida per genitori e scuole, e servizi attivi che aiutano a proteggere i minori.
Come prevenire i rischi di abuso?
Prevenire non significa solo “controllare”, ma soprattutto educare e formare. Adulti informati e bambini consapevoli sono la migliore difesa contro le situazioni di rischio.
Ecco alcune buone pratiche utili:
- Parlare con i bambini in modo chiaro e aperto su ciò che è giusto e ciò che non lo è.
- Insegnare ai bambini a riconoscere i propri confini, spiegando che nessuno può toccarli senza il loro consenso.
- Osservare sempre i cambiamenti nel comportamento del bambino e mantenere un dialogo sereno e continuo.
- Coinvolgere scuole e attività sportive in percorsi di educazione all’affettività e al rispetto.
- Partecipare a corsi di formazione, specialmente se si lavora con minori, per imparare a riconoscere i segnali precoci di abuso e intervenire correttamente.
Per questo, La Caramella Buona organizza regolarmente per educatori, genitori e operatori sanitari e sociali.
Quali sono i programmi di prevenzione disponibili?
Oltre alle iniziative delle scuole, ci sono percorsi specifici come:
- Campagne nazionali di sensibilizzazione, come quelle promosse dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
- Formazione obbligatoria per insegnanti, educatori e operatori sanitari, prevista dalla legge per riconoscere e prevenire l’abuso.
- Centri Antiviolenza, che offrono non solo aiuto alle vittime ma anche attività di prevenzione sul territorio.
- Progetti locali, promossi da comuni e regioni, per sostenere le famiglie e prevenire situazioni di disagio.
Anche La Caramella Buona organizza:
- incontri nelle scuole per spiegare ai bambini come riconoscere i pericoli e a chi rivolgersi in caso di difficoltà;
- spettacoli teatrali, per sensibilizzare tutta la società civile su questi temi.
Prevenire è possibile, soprattutto quando si lavora insieme: parlare con i bambini, formare chi lavora con loro e segnalare tempestivamente situazioni sospette sono gesti concreti che possono salvare una vita.